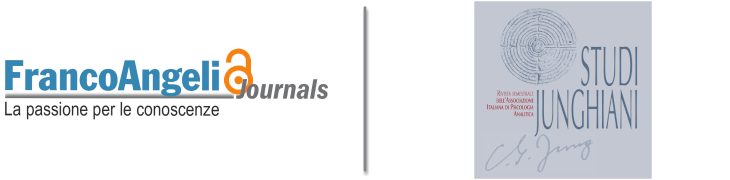
L’articolo sostiene che la self-disclosure dell’analista in seduta sia intimamente legata all’esperienza traumatica e alle pressioni che l’analista sente su di sé e che lo spingono a non ri-traumatizzare il paziente o ripetere con lui dinamiche traumatiche. Fornisce una serie di esempi di tali pressioni e delinea le difficoltà che l’analista può sperimentare nell’adottare un atteggiamento analitico, definito come il cercare di stare quanto più vicino possibile a ciò che il paziente porta in seduta. Ipotizza che la self-disclosure possa essere usata per disconfermare la percezione negativa che il paziente ha di se stesso o dell’analista, o per cercare di indurre il paziente ad acquisire una percezione positiva di se stesso o dell’analista, e che sebbene animati da buone intenzioni, tali interventi possano rivelarsi fallimentari e prolungare l’angoscia del paziente. Vengono forniti esempi in cui l’analista resta aderente alla co-costruzione delle prime dinamiche relazionali traumatiche e lavori attraverso il complesso traumatico; questo atteggiamento viene confrontato e contrapposto ad alcuni atteggiamenti psicoanalitici relazionali.